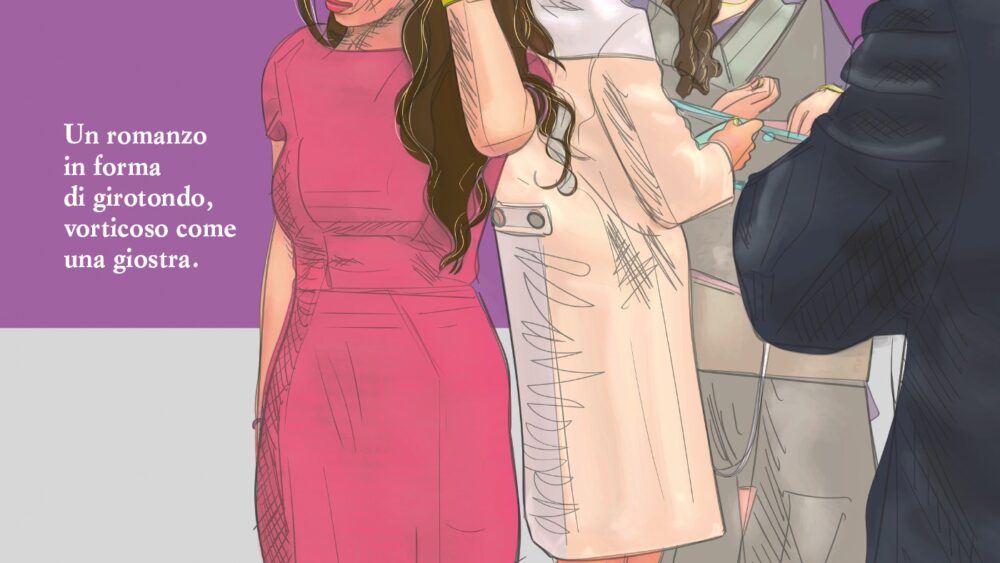(di EMMA DI RAO)
Piovono parole nel nuovo romanzo di Elvira Seminara, “Diavoli di sabbia”, edito da Einaudi. E piovono con lo stesso impeto con cui la pioggia cade quasi incessantemente per tre mesi su una città appena visibile sullo sfondo del dispositivo narrativo.
Piovono parole in un affastellarsi di dialoghi, in un aggrovigliarsi di battute prive di pausa e di respiro. Piovono con una celerità travolgente, proprio come i vortici di sabbia o, meglio, come i diavoli di sabbia che nel deserto del Sahara, ma anche in alcuni paesaggi della Sicilia, s’innalzano d’improvviso fino ad alcune decine di metri per afflosciarsi poi al suolo con la medesima rapidità. Piovono parole in un vero e proprio turbine che può considerarsi esemplificativo di quella relazione interlocutoria che, pur dando luogo nella nostra società a una vera e propria dipendenza, il più delle volte è solo apparente e formale. Ne è conferma il ricorrere, nel testo, di frasi spezzate e sospese che creano una sorta di allucinazione della sintassi dove le parole risultano, in larga parte, divisive e tendono a bloccare il ragionamento invece di assecondarne il fluire, senza contare che finiscono per svelare la sostanziale estraneità di ogni personaggio nei confronti degli altri e di sé stesso.
Piovono parole con un ritmo frenetico che sembra riprodurre, per dirla con Zygmunt Bauman, la condizione liquida moderna in cui il tempo non viene percepito come ciclico o lineare ma frammentato e puntiforme, caratterizzato da una serie di inizi presto superati da nuovi inizi.
A farsi carico in prima persona dei singoli drammi dei personaggi è il lettore, il quale accresce così la propria funzione, che non è più solo quella di colmare i vuoti narrativi, aggiungere il non detto e contribuire alla costruzione del senso del testo. Tale esito, che prevede anche il configurarsi di un lettore-personaggio, è da ascrivere alla scelta dell’autrice di abolire la voce narrante e di rinunciare al ruolo tradizionale di autorevole garante di una vicenda coerente che rispecchi l’organicità del reale.
Una scelta di sicuro audace e innovativa che scompagina non pochi canoni e conferma ulteriormente l’attenzione di Elvira Seminara nei confronti della contemporaneità e delle esigenze che quest’ultima pone anche nell’ambito della scrittura letteraria. I quattordici brevi capitoli di cui il romanzo si compone appaiono, infatti, simili a vere e proprie schegge narrative che riflettono quella parcellizzazione dell’esistenza derivante, a sua volta, da una concezione disorganica del reale. L’esistenza sembra dunque esplodere in una miriade di minuscoli frammenti e tende ad esplodere anche la struttura narrativa, ma alcuni elementi intervengono a darle stabilità, come l’episodio relativo al rinchiudersi di Rodolfo in una stanza del B&B dell’amante, episodio che fa da collante narrativo nella tessitura del romanzo, o come la concatenazione dei dialoghi che consente alle ‘schegge’ di incastrarsi fra di loro con un meccanismo in cui vengono coinvolti tutti i destini dei tredici protagonisti.
Ed è il prevalere dei dialoghi a conferire ai “Diavoli di sabbia” un’indiscutibile dimensione teatrale e a far sì che i personaggi sembrino muoversi su un palcoscenico. Un palcoscenico che esaspera ed accentua la finzione e l’inautenticità della vita senza concedere alcuna possibilità di catarsi.
Dal giudizio espresso da Tommaso al fratello Livio, “Noi siamo fatti per stare in mezzo agli altri, per rapinarci e per salvarci”, si deduce l’impossibilità di prescindere dalla socialità ma anche le notevoli difficoltà che essa pone. Da qui l’ansia di liberazione dalle fitte maglie della rete in cui i protagonisti sono impigliati. Basti pensare alla confessione di Dora di aver inventato il tradimento per liberarsi da un peso che non sapeva di avere o al sogno coltivato da Livio, professore in un liceo, di fare l’istruttore di delfini in Australia o il guardiano delle isole. O, ancora, alla ricerca da parte di Luna dei posti abbandonati o sporchi per trovarvi la libertà, la vita interrotta che riprende. A tale aspirazione segreta va forse ricondotto il ricorrere, nell’ambito lessicale, di termini appartenenti al campo semantico della dissolvenza, come, ad esempio, scontornarsi, disancorarsi, sgranarsi, vaporizzarsi. Dissolvenza che fa da contraltare al peso opprimente delle relazioni reciproche di cui ognuno di noi è vittima.
Non c’è dubbio che il nuovo romanzo di Elvira Seminara ci sorprende e ci scuote fin dall’incipit: “Stanotte è stato bellissimo, l’ho ucciso”, che coniuga la bellezza con l’efferatezza. A parlare è Iris, il personaggio che insieme a Rodolfo inizia la catena dei dialoghi. Personaggio non facilmente decifrabile e perciò di notevole interesse, Iris si trova in prigione per aver ucciso il marito, ma resiste ad ammetterlo e continua a ripetere che ogni notte sogna di ucciderlo in modo diverso. Iris che sposta la sedia perché vuole vedere il cielo – non è superfluo ricordare che il suo nome significa, fra l’altro, personificazione dell’arcobaleno -, Iris che non sopporta che la porta sia chiusa, Iris che dice di non avere segreti, Iris che ha premonizioni e dichiara al suo psicanalista “lei non ha capito”, quasi a sancire l’impossibilità dei sani a capire la malattia, non ha inteso con il suo delitto punire il tradimento, di cui peraltro la letteratura è piena, ma la degradazione e l’umiliazione. Iris, che insegnava Lettere in un liceo, chiama dunque in campo la letteratura, menzionando Simone de Beauvoir, una delle personalità più importanti del Novecento ed esponente dell’esistenzialismo, ma anche Anne Sexton, la poetessa che approdò alla scrittura come forma di psicoterapia, e non dimentica di citare Borges, il narratore di specchi e labirinti.
Ciò induce a ritenere che, come già la Elvis de “I segreti del giovedì sera”, anche questa figura sia dotata di una prospettiva superiore e distaccata che sortisce un effetto decisamente straniante. La conoscenza della letteratura potrebbe insomma conferire a Iris un sovrappiù di coscienza soprattutto rispetto a Rodolfo che, nel proporre alla paziente di scrivere la sua narrazione su “un bel quaderno nuovo”, ricorda lo psicanalista dello sveviano Zeno Cosini. Ma dalla costante frequentazione del patrimonio letterario da parte di Iris si ricava anche un’ulteriore impressione, ovvero che in mezzo a tanta instabilità emotiva e in mezzo al non senso dell’esistenza la letteratura venga a costituire un quid in cui riconoscersi, un appiglio cui ancorarsi saldamente in mezzo a tanta mutevole liquidità.
Peraltro, si parla di libri quando Tommaso dice di sé che amava i libri “al posto di quasi tutto”. Ed ancora, nel brano in Tommaso racconta al fratello che fa “l’ombra, di mestiere”, cioè che scrive discorsi per defunti sconosciuti basandosi sulle briciole e sulle impronte che lasciamo di noi, è molto significativa la replica di Livio: “è un peccato che hai smesso, tutto questo per l’umanità è più utile e religioso di un romanzo”. Sembra infatti di cogliervi un giudizio implicito di natura letteraria secondo cui il singolo frammento, il dettaglio minimo, è maggiormente rivelatore rispetto all’esposizione organica e continuata qual è il romanzo.
A questo argomento è possibile correlare il tema della memoria che nel romanzo è presente in modo obliquo, “un po’ di traverso”, proprio “come gli occhiali di Davide”, e che permea di sé parte del dialogo tra Sonia e la figlia Alga che lavora ininterrottamente per l’intera giornata in un hotel. Qui sembra che la dimensione virtuale sia preferibile, in quanto non contaminata dalla realtà, alla dimensione in cui si vive e che la memoria venga concepita come un ostacolo, come un inciampo o come un arresto. Senza contare che nel dialogo precedente tra Sonia e Samuele, la prima fa notare al suo interlocutore “le mie pareti tutte libere, senza quadri, mensole e stupidaggini. Detesto le testimonianze del tempo, la voce delle cose addosso”, spingendosi ad affermare la propria preferenza non tanto del vuoto quanto dell’emendamento delle cose. Se a ciò si aggiunge la riflessione che il personaggio di Olimpia esprime rivolgendosi a Luna, “Bisogna vivere ogni giorno come se fosse il primo, senza passato, chi se ne frega della memoria, questa mania di spremere i vecchi per estrarne la sapienza, ma che ce ne frega del passato, beviamoci il presente, no?”, non sarebbe errato cogliere in questa esigenza di azzerare la memoria un riflesso della ‘cultura dell’adesso’, del fatto che la cultura contemporanea tende frequentemente a pensare a breve termine.
Al riguardo, appare molto efficace l’immagine della memoria che il personaggio di Vanessa paragona a un’immensa cassettiera con milioni di cassetti contenenti anche frammenti non convertiti in ricordo. Il che potrebbe significare che su di essi è intervenuta la rimozione esercitata dall’oblio o che non sono ancora risaliti fino alla soglia della coscienza o forse, più semplicemente, che sulla memoria non riusciamo ad esercitare alcun controllo.
Ciò che comunque i dialoghi raccontano altro non è, in fondo, che la vita stessa. Quella vita che Olimpia, spiegando la scelta del nome ‘Sciame sismico’ dato a un pub, così definisce indirettamente:
“Incostanza fragilità della terra eruzioni e scosse sciame di pensieri, la vita è un pub, questa è la verità”. Affermazione originale e veritiera che coglie gli aspetti più significativi ed inquietanti dell’esistenza in cui talvolta si corre il rischio di saltare nel vuoto quando non c’è più niente da respirare, come è accaduto a Davide, e di non dormire la notte quando non si ha più niente da sognare. In siffatto contesto, in cui il vuoto finisce per essere più forte del pieno, anche i sentimenti più autentici vengono logorati, spesso per distrazione o per negligenza. Alga dice infatti del suo rapporto con Davide che c’era amore, ma “eravamo troppo distratti per dircelo e conservarlo”. Da qui deriva la perdita per colpa di una società che consuma i sentimenti anche a causa di un eccesso di fretta, come si coglie nelle parole di Sonia alla figlia: “Aspetta, vai troppo in fretta, ti perdo”, o nelle parole rivolte da Manlio a Olimpia: “Volevo solo dirti che non dobbiamo aver fretta, c’è un tempo per tutto. Siamo imprigionati nella freccia del tempo, abbiamo perso l’amicizia di Dio anche per questo, e anche lui ha nostalgia di noi, gli manchiamo, l’ho capito cercando mia madre e i libri della mia infanzia”. Passo di indubbia profondità e levità poetica che mette in relazione il modo in cui viviamo e percepiamo il tempo con la perdita di una certa idea, peraltro umanissima, di Dio.
È certo che un mondo come il nostro, aperto, senza confini di tempo e di spazio, senza alcuna ripartizione, dove tutto è mescolato e contaminato, è un mondo che può dare la vertigine, proprio come il Dust Devil, il diavolo di sabbia, un vortice che ci afferra e ci trasforma. L’inevitabilità della trasformazione è affermata con chiarezza da Olimpia: “Noi siamo corpo e trasformazione”. Una trasformazione per la quale ciò che eravamo ieri non preclude la possibilità di diventare, nel presente, qualcosa di totalmente diverso, e dal momento che ogni punto nel tempo è ricco di potenziale e che ogni potenziale è diverso, si può essere diversi in modi innumerevoli.
La conseguenza è il passaggio veloce da una versione all’altra di sé stessi, un moltiplicarsi dell’io che approda inevitabilmente all’ instabilità identitaria che non sempre è possibile risemantizzare.
Ciò rimanda ad un altro tema che in modo sotteso è presente nel romanzo, ovvero l’ambivalenza, la non univocità della verità, correlata a quel pluralismo prospettico che crea su uno stesso fatto più voci, quasi sempre discordanti. Una verità non solo doppia, come dice Livio a Tommaso, ma anche brutale e limacciosa, cosicché è preferibile non infliggerla agli altri; dialogando con Manuela, egli aggiungerà che “la verità è un abuso, se imposta e non richiesta”.
Di certo, una verità il cui relativizzarsi non offre garanzie di certezze confortanti, nonostante possa declinarsi in termini di ampliamento conoscitivo e di arricchimento interiore. Persino la scomparsa della voce narrante può correlarsi al proposito dell’autrice di non confezionare una verità prefigurata e di lasciare al lettore la libertà di attribuire al testo un significato che scaturisca dal suo animus e dalla sua visione del mondo.
Non può negarsi che una verità così concepita porta con sé una solitudine che niente sembra poter scalfire e che causa spesso una distanza abissale fra i personaggi. Si pensi, ad esempio, alla diversità con cui si percepiscono i rumori: quelli che a qualcuno sembrano suoni emessi da gabbiani ad un altro sembrano il vociare di una rissa; in un altro caso, grida di bambini vengono percepiti come ululati di lupi o latrati di cani. Risulta ovvio che nel caso in cui si dissenta finanche sui rumori, la costruzione delle nostre relazioni diviene sempre più complessa o addirittura fallimentare.
Si tratta di un relativismo che, a nostro avviso, non è soltanto una componente della visione dell’autrice, ma investe anche le modalità di scrittura. Ne sono prova l’oscillazione dei nomi Alga/Olga, Mario/ Manlio, che mette in crisi il primo, fondamentale contrassegno dell’identità, e la presenza di lapsus quali ‘gonne’ invece di ‘donne’ o ‘ingiusto’ invece di ‘angusto’, quasi che le caratteristiche oscillatorie del linguaggio servissero a indicare l’instabilità dei rapporti umani e la soggettività estrema che caratterizza la percezione del reale.
In “Diavoli di sabbia” non esiste, però, solo il mondo complicato degli uomini: accanto ad esso si delinea una natura pervasa e scossa da gemiti, rumori, soffi, tuoni, che per gli animali sono segnali da decifrare, e c’è inoltre una pioggia continua, melmosa e condensata che trascina mucillaggini, ma che potrebbe intendersi, dal momento che ogni cosa è ambivalente, come una sorta di rituale di purificazione. Si fa poi menzione del terzo paesaggio di cui parla Vanessa, ovvero “l’erba sulle rotaie, gli arbusti tra le macerie, il paesaggio anarchico e solitario, a dispetto dell’uomo”.
Numerosi sono i riferimenti all’inizio della pandemia e ai segnali del virus che introducono nel romanzo un’atmosfera di vigilia e di apprensione, la quale, non sfociando in nulla, rimane una sorta di paradigma della precarietà in cui ci muoviamo, precarietà di cui l’immagine della “rosa borderline”, prossima a sfiorire, rappresenta una raffinata metafora.
Elementi che rendono plausibile l’ipotesi che l’autrice abbia chiamato in causa la responsabilità dell’uomo, colpevole di avere reso persino l’Everest una discarica a cielo aperto. Si spiegherebbe, in questo caso, perché il cielo venga definito duro e vendicativo e perché Luna, riferendo un giudizio di Vanessa, affermi che “La natura si sta vendicando dei nostri abusi con una prossima epidemia mondiale”.
Il complesso intrecciarsi, a volte comico e a volte drammatico, delle relazioni umane viene esemplificato nel romanzo per mezzo di personaggi caratterizzati da una vocazione sicuramente narcisistica. Alcuni, però, manifestano pensieri e atteggiamenti difformi, come se la scrittrice avesse inteso affidare loro una speranza di riscatto o, più semplicemente, una chiave di lettura del mondo in grado di contenere le aspirazioni eccessive dell’io.
Intendiamo riferirci alla figura di Luna, la sorella gemella di Vanessa, che, pur non sottraendosi alla tentazione di fare un dispetto all’amante, mostra un profilo improntato all’autenticità dei sentimenti. Mentre Vanessa ama l’ordine e la logica, che definisce non il contrario del sentimento ma un aggregatore di sentimenti, Luna ama i luoghi sporchi e abbandonati perché in essi è possibile trovare la libertà; è solita, inoltre, definirsi una casa incompiuta e diroccata, e non esita a confessare di essere intontita dalla felicità nel fare colazione su una panchina, riverita e circondata dai colombi. Una felicità, la sua, che schiude una limpida, seppure fragile, prospettiva di speranza rispetto a quella concezione pessimistica che affiora dall’immagine del “mucchietto” formato dai pochi giorni felici della nostra esistenza. Commovente, nella sua sobria essenzialità, è anche la risposta che Luna dà a Olimpia in relazione al posto che intende occupare nel mondo: “il mio posto è mia sorella”, quasi uno scatto lirico che nasce dal desiderio di una ricomposizione affettiva. Per questi motivi non crediamo errato scorgere in tale personaggio “l’aria sana della tempesta”, ovvero la possibilità di conquistare una dimensione vitale più autentica e una qualche felicità, ma solo a condizione di non integrarsi completamente con il mondo.
Affine, in qualche modo, a Luna risulta la figura di Manlio, che viene chiamato in causa nelle prime pagine del libro e che torna negli ultimi capitoli. Mario/ Manlio: “Inconscio allineato, in scambio simultaneo, praticamente Jung e Freud cheek to cheek sul nostro cuscino”. Manlio a cui piace ascoltare e a cui mancano pezzi dell’infanzia, Manlio che rimpiange di essere uscito dal sogno “per finire qui, scaraventato nel mondo”, si defila, in un certo senso, dagli altri personaggi.
È fin troppo noto che i termini lessicali rimandano spesso a significati nascosti o ulteriori rispetto a quelli che essi denotano; pertanto, anche l’espressione “scaraventato nel mondo” allude a una situazione priva di ogni causalità ed estranea alla volontà del personaggio che subisce lo stare al mondo con un senso di inerme vuoto. Quasi inevitabile il ricordo di una condizione analoga rappresentata nella novella pirandelliana “Una giornata”, di cui è protagonista un uomo gettato nel mondo, “buttato fuori dal treno in una stazione di passaggio”, che vive un assoluto straniamento. Un’ulteriore, immaginifica analogia potrebbe stabilirsi con lo stato di deiezione presso il mondo di cui parla Heidegger per il quale l’essere ‘gettato’ nel mondo coincide con l’inautenticità dell’esserci.
Ed è ancora Manlio che dichiara di sentirsi “un tombino scoperchiato” poiché avverte la dissoluzione causata non solo dalla pioggia ma anche dall’essere lontano da sé, cosicché non ci sorprende che egli citi una poesia in cui “le persone che sogniamo di notte, quando escono dai nostri sogni si incontrano e si salutano, invisibili solo a noi, e si mischiano al vento della vita”. Un’immagine molto suggestiva che dischiude una prospettiva in cui l’esistenza risulta accresciuta dal sommarsi di vita reale e vita sognata.
Un ulteriore tratto concorre a connotare questo personaggio in una direzione non comune: secondo Olimpia, che chiama in causa anche la luce del tornado, Manlio ha un occhio verde e uno argento.
È quasi superfluo ricordare che nelle trame narrative l’occhio costituisce un elemento essenziale, in quanto tratto somatico e nucleo metaforico, soprattutto quando è guastato da un difetto. Del tutto naturale il confronto con l’occhio strabico di Mattia Pascal che rappresenta il segno di un’identità frantumata e disarmonica sostituitasi ad una concezione unitaria dell’io. Né va dimenticato che l’occhio strabico che guarda altrove è anche l’occhio del veggente, proprio come Manlio che dice “sento che sta accadendo qualcosa, un disastro dell’umanità”.
Bisogna ammettere – ed è un ulteriore pregio – che in questo romanzo di Elvira Seminara tante cose restano oscure e inconoscibili, forse per la presenza di quei crepacci che si aprono solo di sera, e molte altre restano segrete. Non conosceremo mai, ad esempio, il contenuto del biglietto scritto da Rodolfo a Dora, non conosceremo mai il motivo del suo barricarsi in una stanza, forse solo per dispetto o, chissà, per il fatto che l’autrice ha voluto prendersi gioco di uno psicanalista che crede di poter curare la malattia e la diversità, ma è lui stesso il malato.
Tutto è incerto e ambivalente perché incerta e sfuggente è la realtà. Anche la parola ‘fine’ dell’ultima pagina solleva un dubbio: è davvero finita? È sincera Iris quando dice di credere alla propria guarigione o si è presa gioco fin dall’inizio di Rodolfo e di noi lettori, quasi personaggi della vicenda?
Forse l’unica cosa che conta, l’unica certezza è che quella sabbia che prima era diabolica e vorticosa sia diventata leggera, dorata e innocua come la sabbia di Portopalo. Fuori di metafora significa che l’unica cosa che possiamo augurarci è che la vita col suo carico di negatività e di pesantezza ci sfiori appena e che somigli quanto più possibile a un gioco.
Non crediamo tuttavia che sui significati di questo libro sia possibile scrivere la parola ‘fine’. Noi preferiamo, sulla scorta di Italo Calvino, cercare di scorgere cosa si profila in lontananza, negli spazi che nell’ultima pagina si estendono al di là della parola ‘fine’.