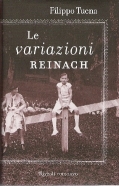
La musica del niente
Di libri sugli orrori della Shoà se n’è scritti tanti, certo. Mai troppi, comunque.
E di romanzi in Italia se ne scrivono decisamente troppi, quasi tutti superflui. Perciò mi aggiorno con colpevole distrazione. Almeno finché non mi capiti (e non mi capitava da tanto, forse addirittura dal lontano 1988 dello sciasciano Il cavaliere e la morte) di rimanere folgorato dalla fulminea coincidenza, in un romanzo fresco di stampa, dapprima sbadatamente svogliato, di bellezza e verità, o meglio – come avrebbe detto Musil – di “anima e esattezza”.
Mi è capitato, questo miracolo, quando mi sono imbattuto nel recente romanzo di Filippo Tuena Le variazioni Reinach. Che è un romanzo (anche) sulla Shoà, ma che a quel terribile capolinea (e precisamente ad Auschwitz) giunge partendo, addirittura, dai salotti proustiani, dalla borghesia ebraica parigina ricca ed estetizzante, dai côtés di Swann e dei Guermantes.
È un libro, questo di Tuena (appena insignito del premio Vittorini), su padri e figli, sul «peso dell’eredità» e sulla trasmissione dei valori. Ed è un libro sui morti, sulle ombre che essi allungano tra i vivi.
Ed è un libro sui libri. Sulle biblioteche, i salotti, le ville, gli edifici, le vie. Su Parigi. Su Proust. Sulla ricca borghesia ebraica. Sul collezionismo. Sulla musica.
Sul Niente («Au même temps je voudrais écrire sur le RIEN. Sur les choses de famille qui passent et sur les gens qui sont englouties par le passé»). E sulla «musica del niente», modulata sulle tonalità dell’assenza, destinata elettivamente alla scomparsa. E rincorsa da uno scrittore che, su una partitura scandita da febbrili «variazioni», rincorre proustianamente il tempo: quello d’una moltitudine di voci senza volto e di numeri incerti, ma anche il proprio, quello di chi in questo gorgo si specchia. E quello, ancora, d’un romanzo da scrivere ma che nel suo farsi accidentato, nelle tortuose spire della ricerca d’archivio e dell’interrogazione esistenziale, è già scritto, si dispiega vivo e palpitante, ma incredibilmente compiuto, davanti ai nostri occhi.
Nel destino di Léon, Béatrice, Fanny e Bertrand Reinach, nel loro precipite inabissamento da uno stato di grazia alla mortificazione suprema del lager, e nelle labili tracce lasciate da quella deriva, lo scrittore riconosce – riconoscendovisi – un’inquietante ricorrenza tematica, un infittirsi d’indizi allusivi al motivo dello scomparire, del dileguarsi, dell’annullarsi. E viene in mente un capolavoro che ora compie trent’anni: La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia, un’altra sparizione sullo sfondo d’un dramma epocale, un altro romanzo-inchiesta che anzi segnò, nell’opera dello scrittore siciliano, una svolta intellettuale e stilistica.
Anche il tempo inseguito è, irreparabilmente, temps perdu, così come gli oggetti depredati dai nazi in quelle raffinate dimore; e l’olocausto, spartiacque della storia, anche in questo segna un’invalicabile cesura: perché da allora, forse, quel tempo non è più possibile “ritrovarlo”, perché da allora non è più possibile evocare una pienezza ormai infranta, ritessere la trama lacerata della memoria individuale e collettiva.
A meno di affidarsi – solido ancoraggio o evanescente chimera che sia – alla suggestione di quella “musica” vagheggiata e vanamente incalzata: una sonata per violino e pianoforte, dissolta nel nulla così come il suo sfuggente autore, Léon Reinach che pur si professava compositeur de musique, ma di una musica ingoiata dall’oblìo e dallo strazio, perciò assai prossima al silenzio e anzi con esso coincidente. E se alla fine della sua recherche, e del libro che la narra e vi si identifica, dopo mille disperati tentativi l’autore inaspettatamente la ritrova, forse è in quell’esile linea melodica – come nella proustiana petite phrase de Vinteuil – che il miracolo del temps retrouvé ha un’effimera replica: dove personaggi e destini, autore e storia, dolore e bellezza, sacrificio e redenzione finalmente convergono.
Dove, se non nell’inferno del lager (e magari nell’orchestrina che ad Auschwitz ritmava l’ultimo viaggio dei deportati)? Perché è in quella voragine che il tempo, il senso, la scrittura precipitarono; e perché, da allora, «solo chi scrive di questo scrive veramente».
Filippo Tuena, Le variazioni Reinach
Rizzoli, 2005
giugno 2005
